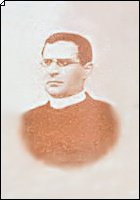La nostra rubrica sugli illustri scrittori calabresi continua e ci porta nel Cosentino, dove oggi racconteremo la storia di Vincenzo Padula. Nato ad Acri il 25 marzo 1819 in una famiglia benestante della buona borghesia locale, figlio del medico Carlo Maria Padula e della moglie Mariangela Caterino, donna assai colta proveniente da una famiglia di tradizione politica murattiana. Venne avviato al sacerdozio e studiò dapprima al seminario di Bisignano, successivamente in quello di San Marco Argentano. Dopo l’ordinazione, avvenuta nel 1843, fu nominato insegnante nello stesso seminario di San Marco Argentano. La sua più vera vocazione era tuttavia la letteratura. Nel 1845 lasciò pertanto il seminario per dedicarsi al giornalismo, partecipando, assieme a un gruppo di giovani amici calabresi antiborbonici radunati attorno a Domenico Mauro, al vivace dibattito che precedette nelle Calabrie la rivoluzione del 1848.

In questo clima maturò la sua prima opera, la novella in versi Il monastero di Sambucina (1843), dedicata allo stesso Domenico Mauro. Collaborò a “Il Calabrese”, un periodico in cui, oltre a Domenico Mauro, scrivevano numerosi letterati, estremisti in politica e romantici in letteratura, fra i quali debbono essere ricordati Francesco Saverio Salfi, Giuseppe Campagna, Pietro Giannone di Bisignano (1806-1869), Biagio e Biagio Gioacchino Miraglia. Nel 1845 venne pubblicato “Il Valentino”, un poema di gusto byroniano andato ormai perduto. In entrambi i poemetti sono molto evidenti gli influssi della moda letteraria del tempo, soprattutto di Nicolò Tommaseo e Tommaso Grossi; è molto evidente inoltre il tentativo di dipingere la società calabrese nelle sue passioni quasi selvagge. Il radicalismo di Padula e dei giovani intellettuali suoi amici era reso più estremista dalle arretrate condizioni delle Calabrie, una regione in cui, assieme ai fermenti utopistici del passato sopravviveva la tradizione giacobina.
Testimonianza dei suoi sentimenti liberali sono alcuni versi sulla destituzione del Ministro della polizia Francesco Saverio Del Carretto e sulla prima guerra di indipendenza.
Come tanti altri religiosi, Padula aderì alla rivolta antiborbonica del 1848, anche se non pare abbia preso parte direttamente ad atti violenti. Durante gli scontri, che si verificarono ad Acri tra la fazione borbonica e quella liberale, perse la vita il fratello Giacomo. Perseguitato dalla reazione borbonica, seguita alla sconfitta dei moti del ’48, gli fu tolto l’incarico di insegnamento al seminario e visse di stenti. Aprì una scuola privata, ma gli fu tolto il permesso; e fece l’istitutore presso famiglie liberaleggianti calabresi, prima presso i Ferrari a Petilia Policastro, poi a Crotone. Nel frattempo traduceva l’Apocalisse e studiava Gioberti e Rosmini.
Nel 1854 si stabilì finalmente a Napoli, dove sperava fra l’altro di rendere la sua cultura più moderna e meno provinciale e di concorrere a qualche cattedra universitaria. Le speranze andarono in parte deluse; pubblicò tuttavia la traduzione dell’Apocalisse e altri versi sacri, e si legò ai pochi intellettuali rimasti in libertà con i quali si dedicò spesso alla compilazione di periodici, soppressi quasi sempre dalla censura. Fondò fra l’altro, assieme a Carlo De Cesare, Federico Quercia e Pasquale Trisolino, il periodico Secolo XIX.
Dopo l’Unità d’Italia si dedicò al giornalismo. Fondò dapprima un giornale di centro-sinistra (Il popolo d’Italia, 1861) e successivamente il periodico bisettimanale Il Bruzio (1864-1865), vicino alle posizioni politiche moderate di Francesco De Sanctis e Luigi Settembrini. In quest’ultimo giornale, scritto quasi interamente da lui, apparvero i saggi meridionalistici raccolti successivamente in Dello stato delle persone in Calabria e il dramma Antonello capobrigante calabrese. Il 28 luglio 1865 anche il Bruzio cessò le sue pubblicazioni.

Nel 1867 fu chiamato dal ministro dell’Istruzione Cesare Correnti a Firenze, allora capitale del Regno d’Italia, come segretario particolare. Con la speranza di intraprendere la carriera universitaria, nel 1871 scrisse in pochi mesi Protogea, un’opera in cui pretendeva di rintracciare le origini semitiche della toponomastica calabrese nel mondo preistorico. Migliori prove della sua cultura dimostrò in alcune pagine latine su Properzio. Nel novembre del 1878 ottenne finalmente dall’Università degli studi di Parma la cattedra di Letteratura italiana (D.M. P.I. 13 ottobre 1878); ma vi rimase solo due anni. Tornò a Napoli nel 1881, ma, a causa delle cattive condizioni di salute, si ritirò nel suo paese natale, dove rimase fino alla morte, sopraggiuntagli l’8 gennaio del 1893, all’età di 73 anni.